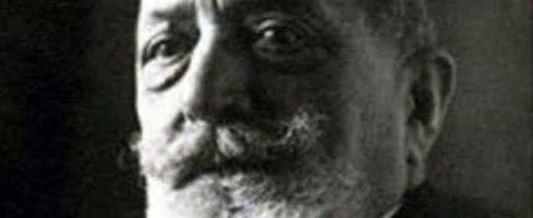Nell’introduzione ad Il fiore della poesia dialettale calabrese (Cosenza: MIT, 1978), Giulio Palange trascrive che Vittorio Butera, il poeta di Conflenti (CZ), visse dal 1887 al 1955.
Sulla falsariga d’un altro volumetto intitolato semplicemente Vittorio Butera (Cosenza: MIT, 1978), con prefazione di Umberto Bosco, ristampa identica d’un’edizione del 1969, Palange, d’accordo con Bosco, afferma che il Butera avrebbe cominciato a scrivere poesie all’età di 44 anni, ovvero, precisa l’aritmetica di Bosco, nel 1921. Trattasi ovviamente di cosucce che andrebbero annotate in calce, se non dessero la netta impressione di leggerezze editoriali.
A scanso di ulteriori equivoci, la prima raccolta delle Poesie di Butera, consistente d’una rigorosa selezione (di fra duemila e più poesie!) di dieci liriche e quaranta favole, pare abbia visto la luce a Roma nel 1949, ossia proprio in casa d’un Trilussa che, assieme a Croce, poteva persino vantarsi d’aver fatto paura a Mussolini, per questo, forse, il Bosco crede che, suo malgrado, un paragone Trilussa-Butera debba essere d’obbligo, anche se il poeta romanesco godeva già da tempo di fama internazionale: nel 1914 era andato in Egitto, e nel 1924 in Brasile. A titolo di curiosità, il suo Lupo e agnelli (Roma: Voghera, 1919) si trova tradotto quasi per intero in calabrese in un volume di sapore anarchico pubblicato a Buenos Aires nel 1933 (Riccardo Cordiferro, Ode alla Calabria). Neanche il Palange si sottrae a simili richiami pur sapendo di farli “a torto e a ragione” e facendoli, come il Bosco, per additarne soprattutto le differenze. Questi, che si autodefinisce calabrese “di città”, pur non riuscendo ad evitare qualche cantonata in questione di glossario, è il primo a rilevare che il Butera inventa lui stesso la propria lingua e che in fondo non deve niente a nessuno. Il ragguaglio più ovvio, e forse meno significativo, consiste nell’uso comune d’una tipologia d’ambiente favolistico che, come si sa, il Trilussa non ha inventato e Butera non ha copiato. Del resto lo stesso Bosco, nella sua prefazione, non tralascia di asserire che il Trilussa rimane per Butera solo un punto di partenza. E non potrebbe essere diversamente: il Maestro della vecchia storia e della battuta scontata e sempre nuova s’ispira ad una filosofia che potrebbe essere tutt’al più napoletana e mai calabrese, ed aleggia in un mondo tutto suo, personalissimo, di cui il Butera non saprebbe neppure immaginarne l’esistenza. Popolarità a parte, ci si trova al cospetto di due poeti che, da individui, non hanno proprio niente in comune. Per temperamento Vittorio Butera non potrebbe giammai ritrovare la pace e la serenità “der savio che s’ammaschera da matto”. Né saprebbe il Butera alludere scherzosamente all’amore coniugale, e tanto meno verseggiare di roba da innamorati, mentre il Trilussa, cogliendo come sempre l’occasione al balzo, crea in quattro e quattr’otto un quadretto d’inverno capitolino e presenta la signora Jole avvolta nello scialle dei tempi belli, rimasto intatto, rosso fiammante, grazie alla naftalina, per poi concludere: Bisognerebbe ritrovà un sistema, / pé conservà così pure l’amore... Il Trilussa prende la vita come viene, e se la gode: Se me frulla un pensiero che me scoccia / me fermo a beve e chiedo ajuto ar vino: / poi me la canto e seguito er cammino / cor destino en saccoccia. Per Butera il destino è una cosa seria, da non portarsi a spasso in saccoccia; più spesso che no è una realtà da maledire.
Per medesimezza d’indole, di sentimenti e di vernacolo, solo la lirica di Michele Pane, nato ad Adami, a due passi da Conflenti, può accostarsi, mutatis mutandis, al verso del Butera. Un accostamento che Bosco non vede di buon occhio, perché il Butera deriverebbe dal Pane momenti poco felici. Chi condivide più da vicino le vicende umane di Michele Pane fa subito notare che la Calabria di questi è quella sognata dall’esilio, fatta di memorie filtrate, come quelle d’ogni emigrante calabrese, mentre la Calabria del Butera è viva, tangibile, palpitante, amara terra che, su per poggi e colline, risale dalla riva manca del basso Savuto fino al ventoso Reventino in una soave gradazione di sfumature verdeggianti che si evaporano nell’azzurro e nel turchese. Di là dalla montagna riposa l’ultimo orizzonte: il Tibet. Sulla riva destra dell’avaro Savuto sonnecchia qualche altro paese di fiaba. Quello di Michele Pane è canto di rondine che sa di non poter tornare; canto ripreso e modulato dal Butera stesso in una lirica dedicata appunto al poeta emigrato. Il Butera è invece ancorato nei pressi del campanile e dà l’impressione di starsene lì dritto a mezza costa, quercia annosa d’impossibile trapianto. Non si maschera di saggezza, non chiede aiuto al vino, e non si arma di falso stoicismo per cantare con alligrizza minzugnara la sua terra natale, la sua gente, ed i lor costumi foggiati dall’atavica e rustica realtà d’ogni giorno; realtà di poeta di paese che non può trovare eco in quelle di poeti dialettali di città.
Il Butera non risolve giammai l’osservazione veristica del suo mondo con una battuta trilussiama; né con un quadretto digiacomiano consistente di pennellate intese a mostrare l’umorismo folklorismo napoletano. Se per contrasto si prende in considerazione il realismo di Ferdinando Russo, pur annullando quanto separa il microcosmo di Conflenti dal macrocosmo partenopeo, il contrasto Russo-Butera si rivela immediato, perché il Butera non si compiace della corpulenza delle sue osservazioni, anzi, se ne addolora, pur cercando di rassegnarsi all’immutabilità della sorte. In questo senso, ed in questo soltanto, esiste un ilio comune fra Butera e Rocco Gualdieri: all’immutabilità della sorte calabrese si contrappone l’inevitabilità d’una morte prematura, sempre in agguato, che presta ali poderose alla lirica del Gualdieri, colpito giovanissimo da male inesorabile.
Circa il verso del Butera, non si hanno difficoltà: il poeta stesso volle differenziare il canto dal racconto, separando la raccolta delle poesie pubblicate in due sezioni dal titolo inconfondibile: Prima cantu... e doppu cuntu. Diventa subito ovvio che la sua lirica non rispetta manco le intenzioni dell’autore, ma sgorga e straripa a misura della piena di sentimenti che travolge il poeta, spesso cogliendolo d’improvviso, a sua insaputa, anche quando vorrebbe semplicemente raccontare. Alligrizza minzugnara apre a mo’ di prologo per avvertire che ogni tanto il poeta dedica alla luna un canto che veramente è solo pianto. Anche Francesco Greco, poeta di Savelli, nella Sila cosentina, ma emigrato in America, sente il bisogno d’iniziare con un sonetto-prologo in cui confessa di cantare solo per calmare il pianto. Torna spontaneo a mente il Prologo de I pagliacci. La confessione del Butera sta quasi ad avvertire che non bisogna prenderlo sul serio quando in ‘U piecuraru e ri cani dice di divertirsi rimirando un branco di cani affamati che attendono invano il miracolo dell’elemosina: il pastore, poveraccio, ha solo un’unghia di companatico e mezzo pane scuro. Le pecore che meriggiano nell’ombra, e che sembrano una cesta di bucato bianco steso sull’erba ad asciugare, non potrebbero non richiamare alla memoria certe ville biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti, e mettono in evidenza, nonostante le apparenze, l’essenza del genuino poetare. I cani, ritti sulle zampe posteriori, paiono evangelisti e ingoiano a vuoto. ‘U quatru e ra tenna è spoglia d’estro poetico e suggerisce che il Butera l’abbia scelta per nostalgia d’un ricordo della propria fanciullezza: la scoperta d’una macchia di muffa dietro una tenda inchiodata ad una parete. Fra la dovizia di rime e ritmi e assonanze fa già capolino la favola, con la comparsa d’un ragno sapiente che pronuncia che la vita è una muffa coperta per truffa da bende di seta. ‘A funtana ‘e Fruntera è poesia d’occasione, riscattata dall’arte buteriana di trasformare la parola in verbum, pregio ancor più evidente in Tuornu a ra scola che, sulle ali del sogno, ricrea l’ambiente degli anni verdi del poeta: compagni di scuola ormai sparpagliati per il mondo; il maestro ormai deceduto, a cui vorrebbe baciare la mano come allora (quando l’insegnamento era ancora una professione di prestigio). Cosi Butera intaglia, scolpisce, crea. Per il calabrese di città, e tanto più per quello d’oltremare, il verso di Butera risveglia tutt’un mondo sopito. L’esattezza dei vocaboli, il lor sapore sorprendentemente aulico (almeno per l’emigrato), oltre a cristallizzare un’immagine, riesce a risvegliare le memorie più impensate, a suscitare le emozioni più vibranti. Il vernacolo del Butera possiede la medesima magia della Zampogna (Natale), che piena or di vento or di lamento suona la ninna ad ogni porta chiusa. Il Butera gioisce davanti ad umili squarci di vita paesana, si emoziona al canto dello zigolo innamorato, canto che muore assieme all’ultimo lamento della canzone amorosa (l’unica del genere!) delle lavandaie fra cui, due, elogiano la bontà delle camicie che stanno lavando. Alla seta, filata da fate e tessuta da ragni, il poeta preferisce il panno di ginestra, prodotto della sua terra, che odora di cotogno e sa di spiganardo. Una rana sportiva, impegnata a fare esercizi sull’altra sponda, non è d’accordo: se la moda pazzesca di portare panni dovesse infatuare anche lei, preferirebbe la seta. Altro esempio di tipologia favolistica che s’inserisce di soppiatto nella lirica pura.
La poesia del Butera commuove più profondamente quando è lievitata dal ricordo, sia quando vuole onorare poeti contemporanei (Mina, lìbbice! e ‘A staffetta, dedicate rispettivamente a Franco Berardelli ed a Miche Pane) sia quando vuole celebrare l’eroismo materno (Mamma Carmela) sia quando rimpiange la fanciullezza, motivo che più frequentemente si ripete. In detti casi, allargandosi a macchia d’olio, da casa a scuola, a monti e paesi circonvicini, tutta la Calabria (quella che dal basso Savuto sale al Reventino) si colora in un affresco gigantesco, veristico, preciso. Il suono della zampogna funge da veliero del ricordo: si materializza l’antico focolare, ed attorno al ceppo avvolto dalle fiamme s’incorpora con magia pirandelliana tutta la famiglia d’un tempo. La vecchia nonna fila come soleva nell’età più bella, ed il poeta, tornato bambino, le salta sulle ginocchia per ascoltarla raccontare.
Nella lirica dedicata al Berardelli e in quella dedicata a Michele Pane, la geografia di casa diventa oltremodo dettagliata. Con gli stormi di passeri fra l’edera torna spontaneo il ragguaglio con il Leopardi più popolare: uno spicchio di luna a mezza falce, minuscola virgola, pende a piombo sulle case della vicina Martirano e arresta il fiato ed il tempo; la pausa dopo il preludio mette in risalto il canto dell’usignoletto maggiolino, che campa solo dall’alba al mattuttino, riducendo così d’un gran pezzo il brevissimo espace ronsardiano. Nella lirica a Michele Pane, il Butera fa suo il dolore della rondine che non torna, e ritesse la stravecchia storia dell’emigrante che se ne muore di nostalgia. Basta chiudere gli occhi per sognare il mondo dell’infanzia e la casa paterna che arde di sole e d’amore. Con la piena dei ricordi si naufraga nella vana voglia di voler tornare: ah, se si potesse! Se si potesse tutti tornare! Tosto la possanza della nostalgia mutasi in speranza, che sembra sorridere sempre più da vicino, fino al punto di far sentire la fragranza dei campi seminati a grano e lino, per chiudere col verso S’è ‘nnu suonno, lassàtime sunnare! Non sfugge la contraddizione intima, perché il poeta, con introspezione calderoniana, ha piena coscienza di starsene sognando. Persino nel momento in cui la forza del desiderio riesce a portare d’incanto dalla Calabria in America la fragranza dei campi seminati, il Butera non riesce a sottrarsi al doloroso dramma dell’emigrato.
Cospicua per assenza – vale la pena di sottolinearlo – la carovana di spasimanti digiacomiani, perché il Butera non si abbandona mai alle sdolcinature d’un di Giacomo minore né si concede il lusso della lirica amorosa. Quello della malinconia è estraneo all’amore. In ordine d’importanza, la Calabria, la mamma e la nonna sono le donne predominanti nella lirica del Butera. A differenza della luna napoletana, quasi sempre nuova, per dire piena, capace di stendere sottili fasce d’argento sulle acque del golfo, di spiare dappertutto, quella calabrese è appena una virgola indifferente nel cielo di Martirano. Se ogni tanto qualcuno, poeta o gatta, le canta una canzone o le rivolge la parola, si ha l’impressione di assistere a un monologo. A Marechiaro, invece, allo spuntar della luna, sussultano le onde del mare, l’allegria fa loro cambiar colore e persino i pesci si mettono a far l’amore. Nel Butera, solo la memoria dell’amico, rievoca, ad ogni fatta di luna, una serenata così dolce da sembrar nata da una corda tremante di violino.
Nel mondo delle favole, la lirica del Butera si affievolisce, sgorga soltanto a sprazzi. Alla magia del vernacolo incontaminato, alla sicurezza del taglio, spesso si accoppia la spontaneità degli spunti lirici, che appaiono un po’ dappertutto come fiori silvestri. Il metro, or lento ed ora spedito, si adatta docilmente alle pieghe del racconto, che è sempre conciso, snellito fino al midollo, senza nulla togliere all’immagine creata e della morale impartita. La gamma si estende da botta e risposta, secche, al dinamismo d’azione capace di riflettere l’irrequietezza d’un Ariosto, come all’inizio di ‘E due pùllule (o due fiocchi di neve, che il Bosco scambia con due farfalle):
‘A(sic) ddestra ed a manca,
Ppè tutti ‘ssi pizzi,
Pannizzi ppannizzi,
‘A nive cadìa.
E, ssùffice e jjanca,
‘Ntramente scinnìa,
Vammagia cardata
E ppur virijata
Ppè ll’aria parìa.
Il poeta or si gode la visione d’una nevicata che cade a pannolini ed ora il mistero d’una nebbia fitta, coagulata sulla piana del fiume, vaporosa, come letto di lana. Alla fine, l’enunciazione della morale è il colpo di scalpello che sigilla il lavoro compiuto. Il Butera ha a disposizione un ingente patrimonio di proverbi e ne fa libero uso, ribadendone a volte verità contraddittorie. In fondo, la morale non è che il pretesto per la creazione del rilievo che la precede.
C’è da rilevare che nel mondo delle favole del Butera non c’è posto né per l’aristocrazia né per la borghesia calabresi: i protagonisti sono spesso animali, uccelli, piante ed oggetti molto comuni. Quando si presenta un essere umano, trattasi sempre di gente umile: pecorai, contadini, un mugnaio, una massaia, un vecchio insegnante d’inutile geometria o un povero diavolo di prete. Man mano che si procede, la Calabria si va popolando di esseri provvisti d’ottima favella e miglior logica, che discorrono con invidiabile dialettica per esprimere la pessimistica concezione buteriana della realtà calabrese. Di quando in quando spira un soffio d’ironia, ma la satira è assente: il poeta presenta il suo mondo come lo vede, senza sforzi per o illusioni di volerlo o poterlo cambiare. Questa è la vita! Visione poco edificante ma realistica. L’originalità non va ricercata nelle conclusioni che ribadiscono, per esempio, che ognuno ha il suo prezzo, che la morte non rispetta nessuno, e via di seguito, bensì nel mezzo per arrivare alla conclusione, nel modo calabrese di ragionare in calabrese, più specificamente nel calabrese di Conflenti. L’azione, che si svolge in un ambiente prevalentemente rustico, conduce a definizioni nuove di morali risapute: il cespuglio punge solo per dispetto; il cane ti dà retta solo quando stai mangiando; i gentiluomini sono come le mosche bianche, perché non esistono; solo a mezzogiorno il piuolo si vede com’è; la provvidenza non può accomodare tutti; la fortuna non dura eternamente. Sufficit! Altro che Trilussa!
A parte l’indubbio valore artistico e la validità autentica del canto e racconto del poeta di Conflenti, il Butera andrebbe meglio conosciuto almeno fra quanti sono ancora in grado di leggerlo e capaci di capirlo.