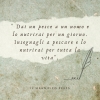di Fiore Sansalone
Parte Prima
''U tempu de la strina è venutu a nume ‘e tutti quanti ve salutu", inizia così il tradizionale canto popolare calabrese tipico rituale del periodo natalizio, che da anni, ad iniziare dalla vigilia del Santo Natale fino al giorno dell’Epifania, si canta davanti alle case di amici e parenti in segno di augurio e di buona fortuna.
Un’antica tradizione che si perde nella notte dei tempi e se anche oggi in alcuni luoghi del cosentino viene considerata come vera e propria tradizione di fine anno, ha sicuramente perduto il suo originale significato.
Il termine strina deriva dal latino strenna che significa dono. Nella cultura popolare è credenza che 'u capudannu abbia una forte influenza sulle azioni dell’uomo: non lavorare o soffrire di qualche male in detto giorno significa avere poca fortuna per tutto l’anno.
«Gli antichi Romani credeano che le cose incominciate il primo di gennaio erano ben augurate e di sicura fortuna: perciò i magistrati prendevano allora possesso delle loro cariche, e gli artigiani soleano dedicare all’esercizio della loro arte un breve momento di quel giorno, benchè festivo».
Nell’antica Roma, al principio del nuovo anno, vi era l’uso di invitare a pranzo gli amici e scambiarsi a vicenda vasi di terracotta ricolmi di miele, datteri e fichi, accompagnati da piccoli ramoscelli di alloro, detti strenae, come augurio di fortuna, salute e felicità.
«Lo scambio delle strenae» era in origine, prima dello spostamento del Capodanno a gennaio, un’antica usanza primaverile del 1° marzo. In quel giorno si sostituivano i vecchi rami d’alloro con nuovi davanti alle porte del rex sacrorum, dei flamini maggiori, delle Curie e del tempio di Vesta. Quei rami erano connessi al simbolismo dell’Albero Cosmico che offriva la sua energia al cosmo per il rinnovamento dell’anno.
Analogamente i Romani cominciarono ad offrirli agli amici e ai parenti come portafortuna. Strenae eran detti perché venivano staccati in un boschetto sulla via Sacra consacrata ad una dea di origine sabina, Strenia, apportatrice di fortuna e felicità. I primi a raccontare di tale usanza furono il poeta latino Plauto e lo storico romano Svetonio che nella loro opera “I dodici Cesari”, nel raccontare della vita di Cesare Augusto, scrivevano: «Tutti gli ordini cittadini gettavano ogni anno in un grande stagno di acqua, sito nei pressi del Foro, chiamato lago Curzio, delle monete per un voto fatto per la sua salute; e ancora anche in sua assenza per le Calende di Gennaio”. L’imperatore “comprava con queste somme statue di dei che consacrava nei vari rioni della città». Il dono (strena) diventò consuetudine e al capodanno questi riceveva, anziché danaro, un regalo d’oro dal popolo o dal Senato.
Dall’antica Roma l’uso delle strenne si tramandò di popolo in popolo fino ad arrivare ai nostri giorni. 'U primu de annu ogni buon padre di famiglia fa la strina ai propri figli, il padrone la fa ai servi e ai coloni regalando loro una piccola somma in denaro come augurio; allegre compagnie la fanno ad amici e parenti cantando in piena notte il caratteristico ritornello augurale:
Chi Diu ve manni tanti boni anni
quantu allu munnu se spannanu panni;
chi Diu ve manni tanti boni misi
quantu allu munnu cce su sordi e turnisi.